PROBLEMI DI VITA E DI ARTE
Da Scotellaro a Verga
di Tommaso Fiore
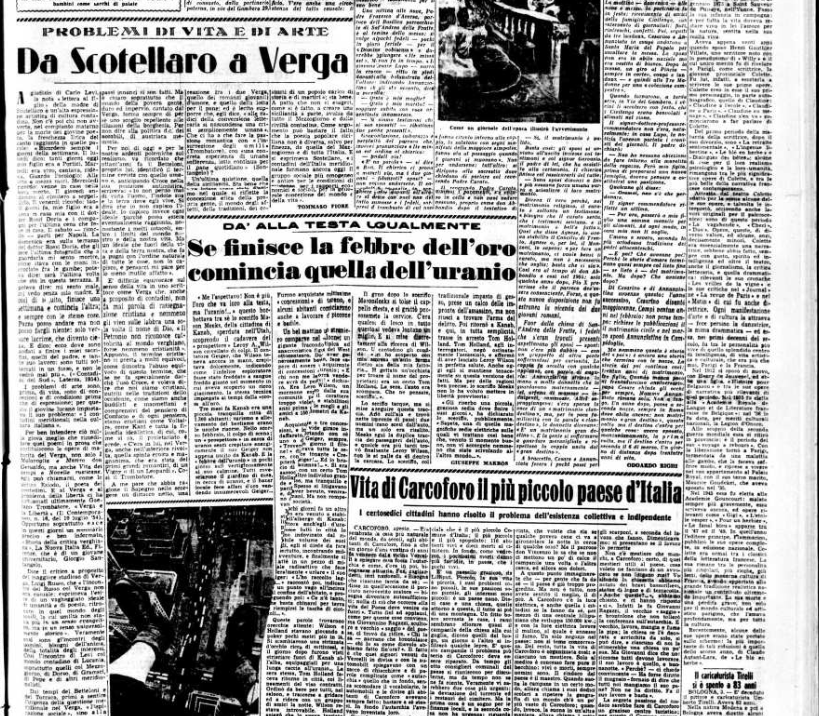
A giudizio di Cario Levi, la nota «lettera al figlio» della madre di Scotellaro è un'alta espressione artistica di cultura contadina. Non c'è poi chi non avverta, nel compianto materno per la morte dei giovine poeta, la freschezza lirica del canto raggiunta in quelle parole: «Ricorderò sempre i giorni della settimana. Il lunedì dico: tanti giorni oggi mio figlio era a Portici. Martedì era vivo, cantava, rideva. Guardo l'orologio: Alle otto e mezza morì. Mercoledì ricordo: venne in casa nella bara morto, il giovedì andammo al cimitero a seppellirlo. Il venerdì ricordo: tanti giorni fa, mio figlio era a cena in casa mia con il dottor Rossi Doria e i compagni per l'ultima cena che fece in casa. Il sabato - ricordo - partì per Napoli. La domenica era sulla terrazza del dottor Rossi Doria, che gli fece l'ultima fotografia che a guardarla mi sento morire, come stava con le mani incrociate tra le gambe; poteva dire: sarà l'ultima volta che sto in questa terrazza. E poteva dire: mi sento male, mi vedo senza mia madre. E così di seguito, finisce una settimana e comincia l'altra; e sempre con le stesse cose. Pazza posso andare ma non posso fargli niente: solo versare lacrime, che divento cieca. E dico: ecco dove sono andati a finire i miei sacrifizi, quelli del padre, e tanto suo lavoro: sono tutti sotterrati in un fosso, e non lo vedrò mai più, («Contadini ni del Sud», Laterza, 1954).
I problemi di arte sono, prima, di vita, sono di concezioni e di condizioni prima che di espressione; per questo il giovine lucano impostava Il suo problema: «i contadini meridionali nella cultura italiana». Per ben intendere ciò nulla giova meglio che rimeditare quei poemi in prosa che costituiscono le opere di maturità del Verga, non solo I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, ma anche Vita dei Campi e Novelle rusticane, egli può chiamarsi, come I’ antico Esiodo, il poeta del contadini. E al Verga e al problema della libertà ci ha richiamati ultimamente Gaetano Trombatore, «Verga e la Libertà» (Il Contemporaneo, n. 16, del 10 luglio '54). Opportuno soprattutto esce in questi giorni un sommario preciso ben informato, «Storia della critica verghiana», La Nuova Italia Ed., Firenze, che è di un giovane universitario, Giorgio Santangelo.
Dice il critico a proposito del maggiore studioso di Verga, Luigi Russo, che «l'incontro del Russo col Verga non era casuale: esprimeva l’esito di un vagheggiato ideale di umanità e di poesia, ritrovato in quel mondo degli umili, la cui umiltà non stava più in un senso evangelico, ma in un senso universalmente storico». Veramente così sono gl'incontri degli uomini, bisogni dell'anima, della totalità degli interessi. Così l'incontro di Levi col mondo contadino di Lucania, soprattutto quelli col Mezzogiorno, di Dorso, di Gramsci, di Pepe e di altri meridionalisti.
Dai tempi del Betteloni, del Torraca, primi a sentire l'urgenza della questione meridionale nel Verga, « l'ispirazione sociale», sino alla polemica semisecolare del Croce contro l'insinceritàdella vita della letteratura, specie dannunziana, molti passi innanzi si son fatti. Ma è chiaro soprattutto che il mondo della povera gente, duro ed impervio, cantato dal Verga, forma sempre di per sè uno scoglio repellente alle illusioni della borghesia. Per non dire alla politica d.c. dei notabili, di austriaca memoria.
Per noi di oggi e per le nostre ardenti polemiche sul realismo, va ricordato che ottant'anni fa Il Betteloni, proprio lui, identificò il termine verista con quello umano e, anticipando Croce nella sua opposizione antimistica, scriveva: «lo non perdo mai di vista l'uomo, l'indole sua e la terra dove egli vive. Si dirà che io non capisco l’ideale. lo capisco invece ogni ideale purché possa essere eventualmente raggiunto, nonostante i molti ostacoli, entro i limiti del mondo nostro e della nostra vita. Ma un ideale che fuori della vita e della terra nostra, che fa a pugni con l'ordine naturale di tutte le cose, non lo capisco, e pensarci mi pare per lo meno inutile affatto».
È difficile equivocare sul senso della vita in uno scrittore come Verga che, anche a proposito di contadini, non fa mai parola di rassegnazione cristiana e nemmeno gli vien sulle labbra una sola volta il nome di Dio. «Il Petronio non riconosce cattolicità al mondo verghiano, forse nemmeno cristianità». Appunto, il termine cristiano si presta a molti equivoci, come dimostra l'abuso equivoco di questo termine, che se ne fa specialmente dacché l’usò Croce, e voleva dire che noi siamo cristiani, nutriti nelle tradizioni dell’occidente, come siamo anche buddisti e maomettani e comprensivi del pensiero di Confucio e di ogni pensiero, siamo cristiani come Voltaire, come Kant e tutta la filosofia idealistica, di cui, come si sa, il proletariato è I’erede. «C'era in lui, nel Verga, anche nell'interiore rivolta, quella spinta eroica e magnanima, che era stata dei primi grandi romantici, di un Vigny o di un Leopardi ». Così il Trombatore.
A me pare che abbia ragione il Sapegno nello scorgere un distacco netto, una reazione fra due Verga, quello dei romanzi giovanili d'amore, quello della lotta per il pane: ed è lecito supporre che, egli dice, e «alle radici della conversione letteraria si nascondesse una crisi semplicemente umana». Che ci ha a che fare la passione romantica con «l'insurrezione degli umili» (Trombatore), con «una concreta esperienza di umana sofferenza, lotta continua per il pane quotidiano » (Santangelo)?
Un'ultima quistione, quella della sicilianità. Sta bene che vive intensa come stato d’animo nel quale si riflette la concezione etica della propria gente, il mondo degli affetti, delle tradizioni, del costumi di un popolo carico di storia e di martiri»; sta bene. A patto che non si esageri, come si è fatto, a creare una sicilianità a parte, avulsa da tutto il Mezzogiorno e dalla civiltà contadina. Come argomento può bastare il fatto che la poesia popolare siciliana non è diversa, salvo per finezza, da quella del Mezzogiorno e di tutta l'Italia. E si esprimeva Scotellaro, «i contadini dell'Italia meridionale formano ancora oggi il gruppo sociale più omogeneo antico per le condizioni di esistenza, per i rapporti economici e sociali, per la generale concezione del mondo della vita».
Il Paese 4 agosto 1954
